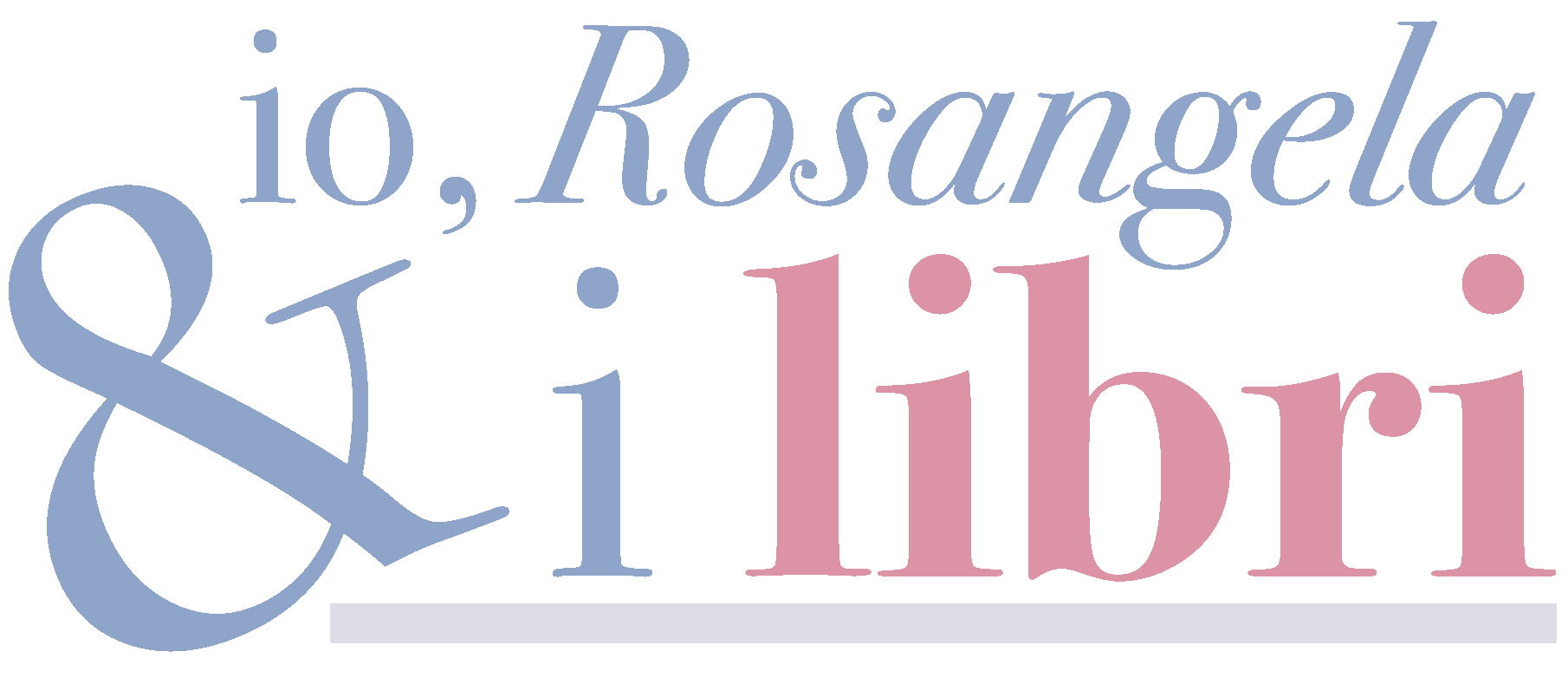L’appello
- di Alessandro D'Avenia
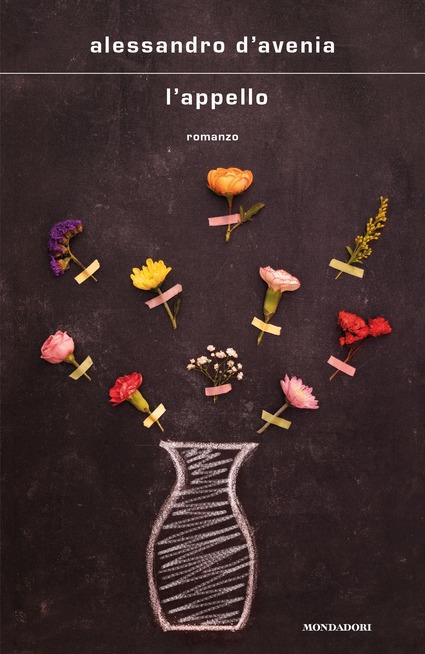
“Sono Omero Romeo, il vostro insegnante di scienze. E sono cieco”. E’ con queste parole, decisamente senza troppi filtri, che il professor Romeo si presenta alla classe. E’ il giorno in cui ha deciso di compiere un altro passo avanti nel viaggio di adattamento alla sua nuova vita da quando, cinque anni prima, ha perso totalmente la vista. Ha sfidato se stesso e i limiti evidenti che legano quella professione e la sua condizione per accettare questo incarico. Un quinto liceo, una classe difficile, dieci ragazzi considerati le pecore nere dell’istituto. Ma questo non rappresenta un problema per Omero perché il dramma che ha vissuto gli ha insegnato che esiste tutto un mondo schermato da ciò che gli occhi ci restituiscono; ha dovuto necessariamente porci attenzione e ne ha fatto un punto di forza per rapportarsi agli altri da una visuale mutata.
“Dal momento che io non posso vedervi, dal vostro nome dipenderà la vostra stessa vita…Per questo svolgeremo l’appello nel modo che adesso vi spiegherò… Dopo aver pronunciato il vostro nome, racconterete cosa lo definisce meglio, come se doveste descrivere un minerale nelle sue manifestazioni essenziali…”.
“Ma perché? Che cosa vuole che ci sia sotto un nome?”.
“Salvare un nome. Per questo faccio l’insegnante… Niente di sentimentale, pura scienza: fino a che non lo identifichi e non gli dai un nome un fenomeno non esiste. Voi siete i fenomeni per i quali a me è chiesto di stabilire il nome preciso e l’appello è la formula completa che salva il mondo.“
A partire da questo appello innovativo il professor Romeo offrirà alla classe un modo differente di insegnare e un modello diverso di scuola che i ragazzi non solo accoglieranno con convinzione, vedendone su loro stessi gli effetti dirompenti, ma che diventerà uno schema da proporre a tutti gli altri studenti quale segno di rottura con ciò che lo ha preceduto.
Dalla sua condizione di uomo evidentemente fragile, sfruttando quella dimensione di dolore condiviso che non può che azzerare le distanze, Romeo insegnerà agli studenti che tutto ciò che li circonda, a partire dai fenomeni con i quali la natura si rivela, è legato da un reciproco rapporto armonico prescindendo dal quale nulla può essere compreso. Ogni aspetto della realtà può essere avvicinato partendo dagli strumenti interiori di cui ciascuno di noi è dotato con un risultato sempre efficace aldilà di ciò che è giusto o sbagliato giacché siamo noi con le nostre storie a definirlo.
“Le cose non sono mai del tutto fuori di noi, ma aspettano che noi mettiamo a disposizione lo spazio già predisposto per loro…La fisica ha mostrato che concetti come oggettivo e soggettivo sono problematici…la cerniera tra soggettivo e oggettivo è differente per ciascuno e per questo racconterete qualcosa del mondo là fuori che noi non riusciamo a vedere…”.
Alla luce di tutto questo il proprio personale appello deve essere esternato e condiviso. Ciascun nome infatti messo in connessione con ciò che la scuola didatticamente sa offrire può diventare linfa per una vita che nasce e può trovare la sua strada in armonia con quella degli altri.
La scuola quindi non può rimanere didattica slegata dalla vita.
Da qui una inevitabile riflessione su ciò che la scuola è e ciò che potrebbe essere, su come le difficoltà evidenti affrontate dal corpo docente non facciano che spegnere con troppa frequenza il fuoco che dovrebbe alimentare la loro missione.
“La maggior parte degli insegnanti perde tempo a fare domande che mirano a scoprire ciò che l’alunno non sa, mentre la vera arte del fare domande mira a scoprire ciò che l’alunno sa o è capace di sapere”.
Credo che questo romanzo, seppur condito da qualche cliché di troppo, possa essere un valido spunto di riflessione per ciascun insegnante che abbia voglia di ritrovare la spinta iniziale e recuperare il valore immenso del compito che gli viene assegnato, perché il frutto del suo successo professionale lo ripagherà di ogni sforzo.